Il precedente articolo sulla proposta ministeriale di estendere l’insegnamento della filosofia dai licei in tutte le scuole italiane sembra aver colpito nel segno; tanto sui social quanto sui media cartacei e non, si è, infatti, riacceso un dibattito, che sembrava sopito, su che cos’è la filosofia e che ruolo può svolgere nelle strategie e nei programmi culturali ed educativi del terzo millennio. Tra le domande più frequenti che ci hanno incuriosito evidenziamo: Che ne sarà della filosofia?. Sopravviverà?.
Ha ancora senso oggi la filosofia per la comunità umana, per la polis o per il «villaggio globale»? Ed a che serve la filosofia?. C’è bisogno di più filosofia o di meno filosofia nella società in cui viviamo?. Da dove parla oggi la filosofia e quale ruolo le spetta nella formazione delle nuove generazioni?. Per cercare di rispondere a qualcuno di questi interrogativi cominciamo col dire che da duemilacinquecento anni la filosofia sopravvive.
La figura del filosofo e la pratica della filosofia sono da secoli in vita e permangono come indiscussi punti di riferimento etico e culturali per tutte le società in cui la stessa si è sviluppata in maniera esponenziale (permanere vuol sempre dire mutare; c’è un solo modo di continuare a vivere, ed è quello di cambiare, alterarsi; resta vivo solo ciò che muta e si mantiene identico alterandosi: la fissità è propria dell’essere senza vita). Certo molte cose sono cambiate da quando Socrate e Platone muovevano i primi, inaugurali passi della pratica filosofica.
E, senza andare così indietro nel tempo, molte cose sono cambiate da quando Husserl, pressappoco ottanta anni fa, delineava il filosofo come “funzionario dell’umanità”, rilanciando l’intenzionalità (supposta) originaria della filosofia, l’ideale di una scienza rigorosa, vale a dire di una scienza (l’unica) apoditticamente fondata. Ma, portandosi ancora più a ridosso del presente, molte cose sono cambiate da quando, in maniera antipodale rispetto a Husserl, negli anni ’60-’80 del secolo appena passato, si è insistentemente e forse anche a sproposito, si è parlato di «fine» della filosofia, pur senza intendere l’espressione troppo letteralmente e senza fare pronostici troppo azzardati.
In tutti questi mutamenti e turbamenti il logos filosofico è sopravvissuto: la figura e la professione del filosofo permangono, resistono, calcano ancora la scena, sono presenti nel panorama culturale e sociale, quando non politico, e ancora attirano e formano giovani menti, nuovi adepti. E non solo. Essere filosofi è infatti un destino che dura dal tempo di Platone, se non di Parmenide o Eraclito, e che tutti ci concerne. In un certo senso noi – che nasciamo in una precisa area del globo terrestre, – siamo obbligati ad essere filosofi (tutti, senza distinzione), non possiamo scrollarci di dosso l’abito filosofico, anche quando ci occupiamo di letteratura o non ci occupiamo affatto di cultura, poiché tutto il nostro discorso pubblico è intessuto col filo del logos filosofico. In questo senso la filosofia non ha bisogno di conquistarsi uno spazio pubblico, l’ha già, la sua presenza è anzi pervasiva. Ciò fa sì che non possiamo nemmeno scegliere di voltare pagina, di diventare altro (se non nelle forme insufficienti e impotenti dell’anti-), poiché pensare filosoficamente è piùo meno lo stesso che parlare la lingua che parliamo (con la sua grammatica e la sua sintassi), passata attraverso il setaccio di una certa scrittura.
La filosofia (a seguito di ripetuti tentativi di alcune generazioni di filosofi contemporanei) è stata vissuta ed interpretata in questi ultimi decenni come un esercizio di radicale consapevolezza della finitezza, della storicità, della contingenza, della non universalità del proprio metodo e del proprio sapere, quindi di ogni altro metodo e sapere, producendosi a questo scopo in una auto-genealogia, in una paziente e meticolosa auto-biografia. In questo solco, un considerevole numero di filosofi “continentali” si è in questi decenni variamente impegnato a prendere atto (e a trarre le principali conseguenze) della «circolarità» del comprendere, vale a dire di quel costitutivo legame tra precomprensione e comprensione che Heidegger ha messo in luce in “Essere e tempo”. Da quando Heidegger in “Essere e tempo” ha formalizzato la circolarità del comprendere (e del conoscere, anche di quello scientifico, beninteso), l’immagine ma anche il concetto della circolarità è rimasta nella coda del nostro occhio. Ora, scrive Heidegger in un passo famoso, «se si vede in questo circolo un circolo vizioso e se si mira a evitarlo o semplicemente lo si “sente” come una irrimediabile imperfezione, se ne fraintende la comprensione. Vi sono stati e vi sono più modi di vivere la circolarità a fondo».
Vi è un modo, all’apparenza il più radicale e conseguente, che conduce in ultima istanza a una forma di paralisi che ci interroga. Esso è riconoscibile per un accento, una insistenza per così dire “negativa” nel sottolineare la conseguenza della circolarità. Vale a dire: se l’esperienza è un circolo, nel senso accennato sopra, allora ogni dire, quello filosofico in testa, a dispetto del suo tradizionale (metafisico) modo di concepirsi e proporsi, è condizionato, provvisorio, insufficiente, non è e non può mai essere un dire puro, un dire stabile, un dire tutto; ogni sapere, ogni discorso è costitutivamente parziale, riflesso di quella precomprensione o di quella vita materiale che caratterizza ogni tempo ogni contesto e che continuamente muta, mutando di conseguenza anche saperi e discorsi, dischiudendo nuove rivelazioni di senso e assegnandone
altre al silenzio, all’inesistenza, al nulla.
Così, se ci collochiamo su un piano diacronico, ciò di cui faranno esperienza coloro che verranno dopo di noi, ciò che intenderanno con le parole (se ancora le diranno «uomo», «filosofia» o «università» sarà molto diverso da quello che noi intendiamo, di cui noi facciamo esperienza; «diverso», e non più o meno vero, più o meno reale. Ma questo vale già per noi stessi e le nostre stagioni di vita. Se ci situiamo invece su un piano sincronico, dobbiamo prendere atto che molto diverse già sono le cose che noi vediamo e diciamo rispetto a quelle che vedono-dicono i nostri contemporanei appartenenti ad altre «precomprensioni» o «vite materiali».
Dunque, una consapevolezza filosofica all’altezza della circolarità in questione suggerisce al filosofo non ingenuo di non lasciarsi andare troppo facilmente o enfaticamente a discorsi sull’uomo e sul mondo, sul presente e sul passato, sul bene e sul male, come se il suo pensare e il suo dire fossero puri, cioè quelli di un angelo, come se piovessero direttamente dal cielo e non sorgessero invece da quella fetta di terra, da quella vita materiale –questa, non un’altra – di cui innegabilmente sono figli. Un certo numero di discorsi sulla vita e sul mondo saranno ovviamente inevitabili, ma filosoficamente non ci si dovrà attardare sui contenuti di quei discorsi; bisognerà piuttosto insistere sulla loro strutturale impossibilità, provvisorietà, particolarità, inattendibilità.
Abbiamo detto sopra, in maniera fugace, riflettendo sulla circolarità del pensiero e della conoscenza, caratteristiche della filosofia, tra la «vita materiale» e «le idee che gli esseri umani si fanno della loro condizione e in generale di quella che essi ritengono sia la “realtà” delle cose», che non solo queste idee mutano con l’inesorabile mutare nel tempo delle precomprensioni, ma che, su un piano sincronico, diverse sono le cose che noi vediamo-diciamo rispetto a quelle che vedono e dicono i nostri contemporanei appartenenti ad altre «precomprensioni» o «vite materiali».
Ora, se da una parte tale diversità è sufficientemente documentata, dall’altra non è detto che essa sia sufficientemente pensata. La diversità è tale infatti solo in relazione a un elemento comune. Se fosse assoluta, pura, essa non si manifesterebbe affatto come tale, sarebbe un nulla, letteralmente illeggibile, impensabile: una assoluta differenza equivarrebbe a una assoluta indifferenza. Una diversità può manifestarsi come tale solo sullo sfondo di una comparazione possibile, che implica un terreno comune (non ha senso dire: il canguro è diverso dalla casa, mentre ne ha dire: il canguro è diverso dal topo). È solo a questa condizione che possono darsi ed essere riconosciute delle diversità, che si può parlare di un diverso mondo, di una diversa lingua, cultura, concezione eccetera. La diversità implica comparabilità e quindi identità a un più profondo livello. Quando si invoca la diversità come prova di una assoluta fluttuazione, bisognerebbe tenere conto che il prodursi delle diversità e del loro riconoscimento presuppone una identità e un orizzonte di accomunamento. Allora, oltre alla precomprensione, al sapere comune («ciò che tutti sanno e sanno fare più o meno») che caratterizza un’epoca e un contesto, per esempio noi abitanti di una zona della terra e di una certa cultura, vi è anche e necessariamente un sapere comune tra coloro che hanno saperi diversi, vi è una «tipica» che li attraversa e li rende, appunto, diversi e perciò comparabili.
Lo diceva a suo modo Merleau-Ponty in “Senso e non senso”: «Non raggiungiamo l’universale abbandonando la nostra particolarità, ma rendendola un mezzo di raggiungere gli altri, in virtù di quella misteriosa nella nostra differenza e nella singolarità della nostra esperienza si attesta lo strano potere che quest’ultima ha di passare in altri, di ri-compiere gli atti d’altri, e quindi si trova fondata in una verità a cui, come diceva Pascal, non possiamo né rinunciare né accedere in pieno». Non è in nostro potere far calare il sipario sul logos filosofico, decretarne la fine, congedarlo per raggiunti limiti di età. Dopo la riflessione sulla circolarità che ci ha così profondamente attraversato, si tratta allora di non cedere né alla scorciatoia di un dogmatismo di ritorno né a quella di un relativismo condito di pietas o di un narcisismo compiaciuto e dolente. Forse non è privo di significato il fatto che oggi un altro modo, esattamente opposto, di rapportarsi al circolo sembri prendere il sopravvento.
L’altro modo, detto rapidamente, è una messa tra parentesi, una censura o un rifiuto da saturazione, da allergia sopravvenuta, del discorso sulla «circolarità». Una quota di filosofi in significativo aumento (non solo appartenenti al variegato fronte degli “analitici”) stigmatizza sempre più decisamente gli esiti immobilizzanti e deresponsabilizzanti cui è potuta giungere una certa flessione della linea ermeneutico genealogico-decostruttiva. Ed allora basta con questa circolarità, liberiamoci finalmente da questa ossessione auto-critica e auto-biografica, con le conseguenze nichilistico-relativistiche annesse, badiamo al sodo, dedichiamoci ad affrontare i problemi, ci sono tante cose da dire, ben più interessanti del fatto che ogni nostro dire non è assoluto e definitivo». Ma noi non siamo affatto costretti a scegliere tra censura e nostalgia.
Ciò che abbiamo voluto suggerire è che tanto quella nostalgia e quella paralisi quanto la censura cui abbiamo ora accennato contengono una incomprensione o una riduzione del significato dell’esperienza. Assumendoci la responsabilità di dire quello che vediamo, fedeli al contegno critico ereditato, consapevoli della nostra parzialità, noi partecipiamo all’esperienza della verità, nel nostro rapporto infinitamente aperto con essa. Della verità vi può essere infatti esperienza. E andare alla ricerca della verità vuol dire fare filosofia.
Giacomo Marcario
foto medium.it


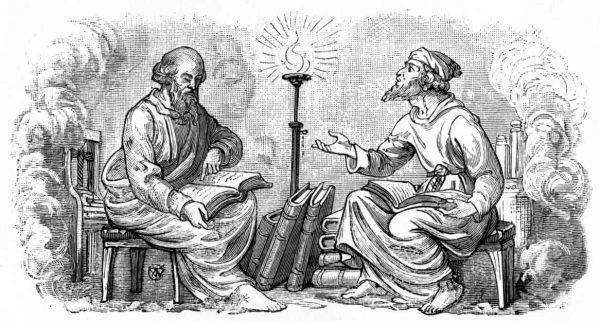





 Attendere un attimo...
Attendere un attimo...


